La difficile prospettiva del multiculturalismo
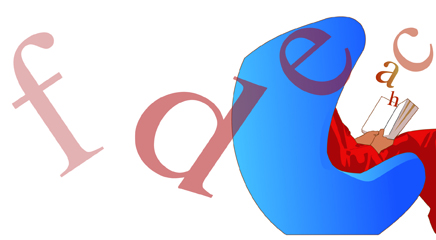 I LUOGHI DELLA PAROLA/APPROFONDIMENTI
I LUOGHI DELLA PAROLA/APPROFONDIMENTI
UN INCONTRO DI CULTURE
di Luca Tenneriello
La civiltà ha avuto la meglio sulla barbarie
quando la barbarie dominava il mondo.
John Stuart Mill
Negli ultimi decenni in collegamento con il realizzarsi di una crescente unione globale (come spiega Singer 2003, specialmente alle pp. 172-223) la riflessione sui problemi etici collegati all’incontro o scontro tra diverse culture […] ha avuto un ampio sviluppo[1].
In effetti è proprio a partire dalle istanze che giungevano – e giungono – da nuovi gruppi etnici e minoranze nazionali che si è sviluppato quel filone di pensiero chiamato multiculturalismo, «volto a definire le basi etiche di una strategia di trattamento delle minoranze (etniche, religiose, culturali) da parte delle istituzioni politiche»[2].
Allargandone la portata, la nozione di “cultura” si trova oggi a dover, volente o nolente, superare i confini nazionali e rispondere alle nuove esigenze che la società odierna richiede. Tale impostazione non deve spaventare, nel timore che venga oscurato l’individuo in quanto tale per porre al centro un essere astratto e dai confini non meglio precisati chiamato “cultura”; l’individuo non scompare, anzi, almeno nella versione liberale del multiculturalismo, esso viene messo sul podio, in nome di quella libertà individuale, diritto fondamentale e inalienabile.
Will Kymlicka (1962-), filosofo politico canadese, è uno dei massimi esponenti di questo filone di pensiero. Sulla scorta di una distinzione tra diritti fondamentali, da garantire a tutti gli individui in quanto uomini, e diritti particolari, da garantire agli uomini in quanto membri di un determinato gruppo culturale, Kymlicka pone la differenza culturale come ambiente necessario e terreno fertile per poter esprimere in maniera compiuta l’identità personale; essa dunque, posto un piano di valori universali, vive e si evolve in maniera dialogica, formata e plasmata dal dialogo con l’altro: in questo consiste precisamente la libertà[3].
Ma questo molto spesso spaventa «quel quinto dell’umanità che gode dell’acqua calda, della mobilità, di cibo sufficiente e degli altri vantaggi del progresso tecnico»[4]. Forse aderendo più o meno tacitamente a un razzismo sempre latente, l’Occidente accetta con difficoltà la soluzione dell’incontro di culture che sembra una buona strada per servire gli ideali della giustizia e del progresso mondiale; tuttavia «la pluralità e la compresenza delle culture non garantiscono di per sé una convivenza civile»[5]. Infatti
L’incontro fra le culture – che, storicamente, appare come occasione e fonte di progresso – può anche farsi scontro, incomprensione, ostilità verso il diverso, percepito come potenziale nemico. L’immigrato resta e viene visto come esule, spesso sospeso fra una cultura abbandonata e una nuova cultura, che non l’accetta in senso pieno, vale a dire accetta le braccia ma non le persone[6].
Le difficoltà, tuttavia, non sono di recente nascita. La tematica viene suscitata, con le dovute differenze categoriali, da un giovane Benedetto Croce (1866-1952), allievo di Antonio Labriola (1843-1904), allora docente di Filosofia morale all’Università di Roma “La Sapienza”:
«Come fareste a educare moralmente un papuano?», domandò uno di noi scolari, tanti anni fa (credo circa trent’anni fa), al prof. Labriola, in una delle sue lezioni di pedagogia, obiettando contro l’efficacia della pedagogia. «Provvisoriamente (rispose con vichiana e hegeliana asprezza l’herbartiano professore), provvisoriamente lo farei schiavo [corsivo mio]; e questa sarebbe la pedagogia del caso, salvo a vedere se pei suoi nipoti e pronipoti si potrà cominciare ad adoperare qualcosa della pedagogia nostra[7].
Il baricentro diventa squisitamente pedagogico. È curioso, al di là della brutalità della risposta circa il papuano da ridurre in schiavitù, che Labriola alluda in seconda battuta ai nipoti e ai pronipoti, quali possibili futuri soggetti – si spera – di una stentata azione pedagogica. Il papuano adulto lo farebbe schiavo, andando contro ogni valore antropologico, mentre con i suoi nipoti e pronipoti potrebbe iniziare un’attività educativa che, posta in quei termini, somiglia più a una “civilizzata” milliana[8], una sorta di “crociata culturale” contro le etnie ritenute “inferiori” rispetto alla dominante e coloniale “razza occidentale”. Si direbbe che Labriola, in questo aberrante inciso, si sia dimenticato della seconda generazione: che fine farebbero i figli del papuano?
Un ambiente, una cultura insomma deve essere ben conosciuta e definita, vissuta da dentro, oserei dire, per far sì che l’azione pedagogica possa arrivare a destinazione, senza che nessuna barriera la ostacoli: tale destinazione è l’uomo stesso, l’individuo; «l’ambiente forgia chi siamo e, in questo senso, l’individuo che agisce è sempre in qualche modo determinato dalla società in cui vive, ma ciò che lo determina è quel che fa di lui la persona che è»[9].
Così la domanda dello scolaro Benedetto Croce «Come fareste a educare moralmente un papuano?» si ripresenta oggi, mutatis mutandis, con un’impellenza decisiva. Chiaramente non si tratta di educare moralmente nessuno, altrimenti avremmo la pretesa di stare nel gregge degli eletti e dettare leggi su come “civilizzare” i “barbari” – o forse quelli a dover essere educati moralmente sono proprio coloro che hanno questa pretesa. Si tratta di trovare quelle strategie che non sfocino solo in una “convivenza tollerante” che ha più il sapore di una “sopportazione”, ma che permettano di realizzare quell’orizzonte cosmopolita fatto di – ancora una volta – dialogo.
E in quest’ottica, forse, quei “figli del papuano”, dimenticati da Labriola, potrebbero trovare piena accoglienza… insieme al loro padre. Non ci sarebbe dunque motivo di schiavitù alcuna, né morale né, tantomeno, fisica.
Dunque, l’orizzonte interculturale, fatto di un armonioso e costruttivo dialogo tra più culture, tra più «modi di essere nella società», sembra un traguardo difficile da raggiungere pienamente.
Mi piace chiudere questo lavoro con le battute finali de Il Re, il Saggio e il Buffone, di Shafique Keshavjee, teologo protestante kenyota, in cui si racconta di un regno immaginario – non molto diverso dal nostro mondo – in cui nessuna cultura etnico-religiosa viene considerata la più degna di rispetto e i sudditi, appartenenti a diversi gruppi religiosi, vivono in armonia tra loro.
Il Re si diresse verso il balcone del suo palazzo. Il suo Regno era immerso in una dolce luce. […] Mai il suo Regno gli era parso così bello. Ma non gli era neanche mai apparso tanto fragile, con tante cose da migliorare. Poi il Re andò a letto pervaso da un’intensa gioia e da una nuova determinazione a servire il suo popolo con giustizia ed equità. Incuriosito da quell’esperienza, ma animato da una felicità profonda, si addormentò solo all’alba. Senza aver chiarito la causa di quel misterioso cambiamento. Che importa? Si era levato un nuovo giorno[10].
[1] E. Lecaldano, Diversità culturali tra liberalismo e conseguenzialismo, in C. Botti (a cura di), Le etiche della diversità culturale, Le Lettere, Firenze 2013, 21.
[2] C. Mancina, Multiculturalismo, in C. Botti (a cura di), cit., 83.
[3] Cfr. Ivi, p. 87-91.
[4] F. Ferrarotti, Lo spettro del multiculturalismo, in N. Sicliani de Cumis, I figli del Papuano. Cultura, culture, intercultura, interculture da Labriola a Makarenko, Gramsci, Yunus,prefazione di F. Ferrarotti, Unicopli, Milano 2010, 9.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] B. Croce, Conversazioni critiche, II serie, Laterza, Bari 19242, 60-61.
[8] Cfr. J. S. Mill, La libertà, L’utilitarismo, L’asservimento delle donne, a cura di E. Mistretta, Rizzoli, Milano 1999, 193 e segg.
[9] I. Salvatore, Liberalismo, istituzioni, contrattualismo, in C. Botti (a cura di), cit., 54.
[10] S. Keshavjee, Il Re, il Saggio e il Buffone. Il Gran Torneo delle religioni, traduzione di C. Bongiovanni, Einaudi, Torino 20002, 196.

